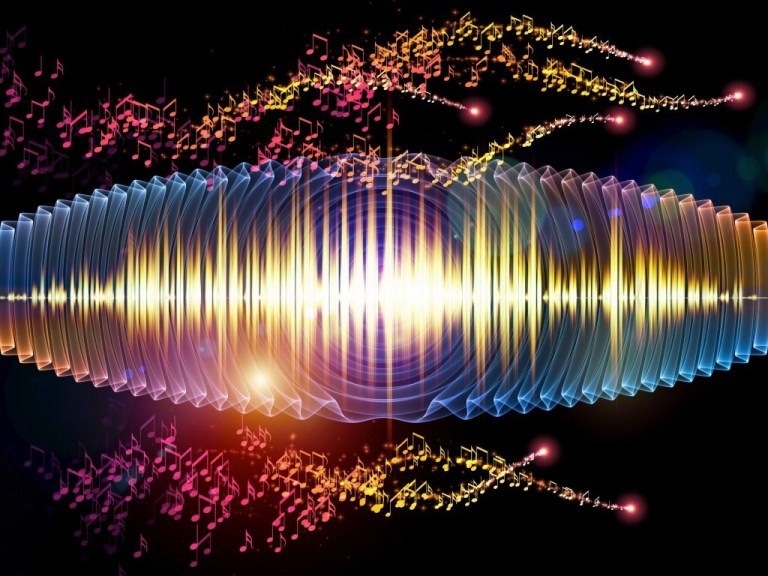I silenzi di Riina - Neppure agli altri boss spiegò i motivi per
colpire Falcone in Sicilia anziché a Roma e di anticipare l’attentato a
Borsellino

di
Roberto Scarpinato | 22 Maggio 2019 - Il Fatto Quotidiano
Più trascorrono gli anni e più cresce la mia sensazione di disagio nel
partecipare il 23 maggio e il 19 luglio alle pubbliche cerimonie
commemorative delle stragi di Capaci e di via D’Amelio.
La retorica di Stato ha i suoi rigidi protocolli ed esige che il
discorso pubblico consegni alla memoria collettiva una narrazione
tragica e, nello stesso tempo, semplice e pacificata, che si può
riassumere nei seguenti termini: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino
furono assassinati perché uomini simbolo di uno Stato che con le
condanne inflitte con il maxiprocesso aveva sferrato un colpo mortale a
Cosa Nostra, mandando in frantumi il mito della sua invincibilità. I
carnefici, i portatori del male di mafia, sono stati identificati e
condannati. Hanno i volti noti di coloro che l’immaginario collettivo ha
già elevato a icone assolute e totalizzanti della mafia: Riina,
Provenzano e altri personaggi di tal fatta. La tenuta di tale narrazione
semplificata è di anno in anno sottoposta a dura prova, per le
crescenti difficoltà di epurare il discorso pubblico da ogni riferimento
alla pluralità di risultanze probatorie che, tra mille difficoltà e
resistenze, si vanno accumulando nei processi (da ultimo il processo
c.d. Borsellino quater, quello sulla “trattativa Stato-mafia” e quello
sulla “’ndrangheta stragista) e che, nel loro sommarsi, lumeggiano una
storia per nulla semplice e rassicurante, anzi scabrosa e inquietante,
intessuta di segreti a tutt’oggi irrisolti a causa del pervicace
silenzio di coloro che ne sono custodi e della sequenza di depistaggi –
processualmente accertati – realizzati in vari modi per occultare
l’emersione di verità che vanno oltre il livello mafioso.
Le complesse motivazioni della campagna stragista del 1992/1993 sono
rimaste nella conoscenza esclusiva di un ristrettissimo numero di capi
perché furono in buona misura tenute segrete sia agli esecutori
materiali che alla quasi totalità degli stessi componenti della
Commissione provinciale di Palermo, l’organo decisionale di vertice
della mafia palermitana. A costoro furono comunicate solo le causali
interne all’organizzazione, cioè la necessità di vendicarsi di Giovanni
Falcone e di Paolo Borsellino perché artefici del maxiprocesso, e di
punire i referenti politici che non avevano mantenuto la promessa di far
annullare in Cassazione le condanne inflitte nel maxi. Ad alcuni fu
anche detto che si voleva costringere lo Stato a trattare.
A tutti furono taciute le causali esterne di quella campagna stragista,
in parte coincidenti con gli interessi dell’organizzazione, in parte
invece talmente divergenti da alimentare progressivamente in taluni capi
e persino negli esecutori, la certezza che Riina e i suoi fedelissimi,
tra i quali i fratelli Graviano e Matteo Messina Denaro, componenti di
quella che Riina aveva definito la “Super Cosa”, non dicevano loro tutta
la verità,
Nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia della mafia palermitana,
per esempio, ha mai riferito alcunché delle riunioni che nel 1991 si
svolsero nelle campagne di Enna e nel corso delle quali i massimi
vertici regionali della mafia discussero dell’attuazione di un complesso
piano di destabilizzazione politica suggerito da entità esterne. In
quelle riunioni fu anche stabilito che gli omicidi e le stragi sarebbero
stati rivendicati con la sigla “Falange armata”, così come in effetti
poi avvenne.
Riina e i suoi fedelissimi non comunicarono nulla delle decisioni
assunte in quella sede agli altri capi della Commissione provinciale di
Palermo nella riunione svoltasi nel dicembre del 1991 nella quale – come
hanno concordemente dichiarato i capi mandamento poi divenuti
collaboratori di giustizia Giovanni Brusca, Salvatore Cangemi e Antonino
Giuffrè – l’unica causale esternata dell’avvio della sequenza di fatti
di sangue programmati fu appunto solo quella interna della vendetta per
l’esito del maxiprocesso che si sapeva già sarebbe stato infausto.
E neppure Riina spiegò in seguito perché aveva ordinato l’improvviso
rientro da Roma del gruppo di fuoco capeggiato da Matteo Messina Denaro
che si apprestava a uccidere Giovanni Falcone a colpi di arma da fuoco
nella Capitale dove egli si muoveva spesso senza scorta, e aveva deciso
di cambiare completamente strategia con l’esecuzione di una strage
eclatante la cui realizzazione richiedeva complesse capacità tecniche in
materia di esplosivi e che, proprio per questo motivo, presentava un
rischio significativo di insuccesso; rischio invece pressoché
inesistente o ridotto ai minimi termini se l’esecuzione dell’omicidio
fosse stato eseguito a Roma da killer di micidiale e sperimentata
abilità.
E neanche Riina spiegò agli altri capi perché nel luglio del 1992 aveva
improvvisamente cambiato programma decidendo di dare esecuzione in tempi
rapidissimi alla strage di via D’Amelio. Una decisione irrazionale e
assolutamente controproducente se valutata esclusivamente alla luce
degli interessi di Cosa Nostra. Il 9 agosto 1992 scadeva infatti il
termine per convertire in legge il decreto legge n, 306 voluto da
Falcone che aveva introdotto il famoso 41 bis dell’ordinamento
penitenziario. Come è stato accertato nel processo sulla trattativa
Stato-mafia, si aveva la certezza che il decreto legge non sarebbe stato
convertito in legge perché in Parlamento esisteva una solida
maggioranza garantista che riteneva quell’articolo in contrasto con i
principi costituzionali. Era evidente, dunque, che la decisione più
conforme agli interessi di Cosa Nostra sarebbe stata quella di attendere
l’esito del voto parlamentare del 9 agosto e incassare il risultato
della vanificazione del 41 bis. Invece eseguire la strage prima del 9
agosto, cambiando i programmi, era assolutamente controproducente perché
– come infatti puntualmente avvenne – era prevedibile che l’ondata di
sdegno popolare conseguente alla seconda strage avrebbe indotto molti
parlamentari a retrocedere dalla loro precedente decisione, convertendo
il decreto legge.
Di fronte alla motivate perplessità degli altri capi, Riina tagliò corto
assumendosi la responsabilità di quanto sarebbe accaduto. E fu a quel
punto che alcuni di loro capirono che Riina taceva qualcosa che
evidentemente non poteva dire neanche a loro. All’uscita dalla riunione
in cui era stato comunicato quel cambio di programma, Raffaele Ganci,
prestigioso capo mandamento, aveva commentato: “Questo è pazzo, ci vuole
rovinare tutti quanti”, come ha riferito il collaboratore di giustizia
Salvatore Cancemi. Lo stesso Cancemi in occasione del suo esame
dibattimentale nell’ambito del processo per la strage di via D’Amelio,
ha dichiarato: “Io ho capito che Riina aveva preso un impegno e doveva
rispondere a qualcuno”. In altri termini aveva capito che Riina stava
assecondando interessi che non coincidevano con quelli di Cosa Nostra e
anzi li ponevano in secondo ordine. Come è stato rilevato nella
motivazione della sentenza sulla trattativa Stato-mafia, l’intuizione di
Cancemi è stata confermata dallo stesso Riina il quale nel corso di una
conversazione intercettata il 6 agosto 2013 all’interno del carcere
Opera di Milano, confidò al suo interlocutore che mentre la strage di
Capaci era stata studiata da mesi, quella di via D’Amelio era stata
invece “studiata alla giornata”, perché, come aggiunse in una successiva
conversazione del 20 agosto: “Arriva chiddu, ma subito… subito… Eh… Ma
rici… macara u secunnu? E Vabbè, poi ci pensu io… rammi un poco di tempo
ca…”. E cioè era arrivato qualcuno che aveva detto che bisognava fare
quella strage “subito, subito” e Riina aveva chiesto di dargli un poco
di tempo.
Erano dunque improvvisamente sopravvenute ragioni che non consentivano
di attendere la manciata di giorni che mancavano al fatidico 9 agosto
1992; ragioni che Riina non poteva esternare ad altri capi e che lo
indussero ad assumersi la responsabilità di quanto sarebbe
inevitabilmente accaduto. Assunzione di responsabilità che derivava dal
fatto che, in ogni caso, l’organizzazione “aveva le spalle coperte”,
come Filippo Graviano, organizzatore della strage e fedelissimo di
Riina, assicurò al capo mandamento Vito Galatolo, il quale divenuto
collaboratore di giustizia nel riferire tale circostanza ha poi aggiunto
che gli uomini d’onore di livello detenuti in carcere erano pervenuti
alla conclusione che “…non è stata Cosa nostra a volere queste Stragi,
ma sono stati… è stato… sono stati dei pezzi dello stato deviati che
hanno costretto cosa nostra a fare questi favori diciamo”.
Ma cosa si apprestava a fare Borsellino prima di quel 9 agosto di
talmente irrimediabile e compromettente da “studiare la strage alla
giornata” pagando l’elevatissimo prezzo dello scontato effetto boomerang
che ne sarebbe conseguito?
In quei giorni Paolo Borsellino aveva programmato due appuntamenti
importanti. Doveva ritornare dal collaboratore Gaspare Mutolo, braccio
destro di Rosario Riccobono noto come “il terrorista” per i suoi
rapporti con i servizi deviati, il quale gli aveva anticipato che
avrebbe finalmente dichiarato a verbale quanto gli aveva in precedenza
confidato informalmente sui rapporti tra esponenti dei servizi segreti e
la mafia. Inoltre doveva recarsi alla Procura della Repubblica di
Caltanissetta per dichiarare quel che aveva appreso sulla strage di
Capaci sulla quale dal 23 maggio non aveva mai smesso di indagare,
raccogliendo una serie di informazioni che lo avevano profondamente
turbato. Nel luglio aveva incontrato il collaboratore di giustizia
Leonardo Messina, appartenente alla mafia di Caltanissetta, il quale era
a conoscenza del piano segreto di destabilizzazione che era stato
discusso a Enna dai vertici regionali della mafia nel 1991 e che aveva
avuto il suo incipit con la strage di Capaci. Anche lui, come Mutolo,
aveva chiesto espressamente di parlare con Borsellino e non aveva ancora
messo a verbale quanto sapeva.
Da altre fonti rimaste sconosciute Borsellino aveva poi appreso notizie
sulla complicità con la mafia di soggetti appartenenti ai massimi
vertici delle Forze di Polizia, come confidò alla moglie Agnese, alla
quale raccomandò significativamente di tenere abbassate in casa le tende
delle finestre perché temeva di essere osservato dai servizi segreti
che avevano una postazione al castello Utveggio di Palermo. Ma non
bastava uccidere Borsellino, occorreva fare sparire anche l’agenda rossa
dove egli aveva annotato tutte le informazioni confidenziali che aveva
acquisito e che gli avevano fornito chiavi di lettura della strage di
Capaci e di quel che si preparava, tali da pervenire alla drammatica
conclusione che accanto alla mafia si muovevano altre forze. La stessa
conclusione a cui sarebbe pervenuta nel 1993 la Direzione Investigativa
Antimafia trasmettendo alla magistratura una informativa nella quale si
comunicava che dietro le stragi si muoveva una “aggregazione di tipo
orizzontale, in cui ciascuno dei componenti è portatore di interessi
particolari perseguibili nell’ambito di un progetto più complesso in cui
convergono finalità diverse”; e che dietro gli esecutori mafiosi
c’erano menti che avevano “dimestichezza con le dinamiche del terrorismo
e con i meccanismi della comunicazione di massa nonché una capacità di
sondare gli ambienti della politica e di interpretarne i segnali”.
Se quella agenda rossa fosse finita nelle mani dei magistrati,
Borsellino avrebbe provocato gravi danni anche da morto e lo scopo
dell’accelerazione della sua uccisione sarebbe stato vanificato. Era
assolutamente consequenziale dunque che dopo l’esplosione di via
D’Amelio soggetti che certamente non appartenevano alla mafia ma ad
apparati istituzionali, intervenissero sul luogo con un un’unica
mission: fare sparire l’agenda rossa. Le pagine dedicate nella sentenza
del c.d. Borsellino quater alla “caccia” all’agenda rossa che si scatena
pochi minuti dopo l’esplosione dell’autobomba, sono agghiaccianti. Un
pullulare di agenti segreti giunti sul luogo ancor prima delle Forze di
Polizia, totalmente indifferenti ai feriti e ai cadaveri e
freneticamente intenti solo alla ricerca dell’agenda che scomparirà
dalla borsa di Paolo Borsellino lasciata all’interno dell’autovettura in
fiamme. Ed è altrettanto conseguenziale alla certezza dei vertici
corleonesi di avere “le spalle coperte” che all’esecuzione della strage
abbiano partecipato soggetti esterni. Circostanza questa nota a
Francesca Castellese, moglie del collaboratore di giustizia Santo Di
Matteo, che – come viene ampiamente riportato nella sentenza citata – in
un drammatico colloquio intercettato il 14 dicembre 1993, poco dopo il
rapimento del loro figlio undicenne Giuseppe (avvenuto il 23 novembre),
scongiurò il marito di non parlare ai magistrati degli “infiltrati della
polizia” nell’esecuzione della strage di via D’Amelio. Infiltrati
rimasti senza volto ma uno dei quali fu ben visto in volto dal Gaspare
Spatuzza, reo confesso della strage, il quale ha rivelato che alle
operazioni di caricamento dell’esplosivo aveva partecipato un soggetto
esterno la cui identità era stata tenuta segreta. Lo stesso Spatuzza ha
dichiarato che le stragi eseguite nel 1992 e nel 1993 gli erano apparse
talmente anomale per le eclatanti modalità terroristiche prescelte
(esplosione di autobombe collocate nelle pubbliche vie con la
conseguente uccisione di cittadini innocenti) da avere avvertito la
necessità di esternare i suoi dubbi sulla loro utilità per Cosa Nostra a
Giuseppe Graviano il quale lo aveva rassicurato chiedendogli,
significativamente, se lui sapesse qualcosa di politica, materia nella
quale egli, a differenza dello Spatuzza, si era dichiarato abbastanza
preparato. A tutto ciò si aggiunge che nella motivazione della sentenza
del processo Borsellino quater la Corte di Assise di Caltanissetta dopo
avere accertato che “le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino sono state
al centro di uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria
italiana”, si è interrogata sulle finalità di tale depistaggio,
lasciando aperti i seguenti interrogativi inquietanti:
“….è lecito interrogarsi sulle finalità realmente perseguite dai
soggetti, inseriti negli apparati dello Stato, che si resero
protagonisti di tale disegno criminoso, con specifico riferimento:
– ai collegamenti con la sottrazione dell’agenda rossa che Paolo
Borsellino aveva con sé al momento dell’attentato e che conteneva una
serie di appunti di fondamentale rilevanza per la ricostruzione
dell’attività da lui svolta nell’ultimo periodo della sua vita, dedicato
ad una serie di indagini di estrema delicatezza e alla ricerca della
verità sulla strage di Capaci;
– alla eventuale finalità di occultamento della responsabilità di altri
soggetti per la strage, nel quadro di una convergenza di interessi tra
‘Cosa Nostra’ e altri centri di potere che percepivano come un pericolo
l’opera del Magistrato”.
Interrogativi ancora senza risposta e che forse possono spiegare anche
il pervicace silenzio mantenuto dai fratelli Graviano sui segreti delle
stragi che coinvolgono centri di potere rimasti temibili e la
straordinaria longevità della latitanza di Matteo Messina Denaro.
*Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo
Fonte:
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-...regge/5197802/